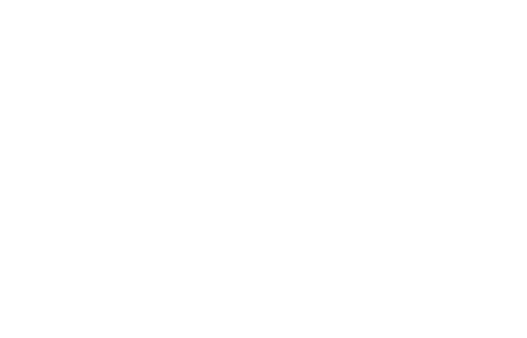La società schermo “accantona” i patti contro la doppia imposizione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10305 del 16 aprile 2024, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione all’esenzione dei dividendi percepiti da un contribuente italiano per il tramite di una società interposta in Stato “white-list”, dovendo quindi approfondire la questione delle “società schermo” e l’abuso del diritto. La Corte, nell’ambito della pronuncia, ha fornito chiarimenti riguardo la prevalenza delle disposizioni interne volte a contrastare fenomeni abusivi rispetto alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e lo Stato di residenza della società interposta, fornendo altresì la nozione di società schermo.
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione i dividendi ricevuti da una società contribuente italiana che deteneva le partecipazioni in una società tedesca, la quale a sua volta controllava una società inglese, che deteneva il controllo di una società localizzata in un “paradiso fiscale”. Quest’ultima aveva distribuito i dividendi, i quali, prima per il tramite della società inglese, e poi tramite la società tedesca, erano giunti nella disponibilità della controllante italiana.
I due giudizi di merito hanno accolto il ricorso, in quanto hanno ritenuto prevalente la disciplina convenzionale e, in particolare, l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania rispetto alla normativa nazionale.
Sebbene i dividendi fossero stati formalmente distribuiti dalla controllata tedesca, gli stessi provenivano dalla partecipata in “paradisi fiscali”, per cui l’ufficio accertatore aveva contestato che la disciplina interna dovesse prevalere rispetto a quella pattizia, poiché la Convenzione non atteneva al caso degli utili rinvenienti da paesi a fiscalità privilegiata.
Norma di riferimento
La disciplina fiscale dei dividendi è contenuta nell’articolo 89 del Tuir, il quale prevede, al comma 2, che “gli utili distribuiti dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare”.
Il comma successivo sancisce che anche gli utili provenienti dai soggetti non residenti, ovvero le società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, siano esenti negli stessi termini degli utili distribuiti dalle società nazionali, tuttavia prevedendo le seguenti condizioni:
- gli utili devono obbligatoriamente essere indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero outbound
- il soggetto non residente non deve essere stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero quei paesi individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del Tuir. In caso contrario, o se il soggetto che distribuisce i dividendi è residente o localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata, affinché gli utili possano essere considerati esenti, è necessario dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
Quindi, la normativa domestica prevede l’integrale tassazione dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sempreché non venga dimostrata la “seconda esimente”, ossia che l’obiettivo della delocalizzazione non sia quello di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero.
Per individuare quali siano gli Stati o territori a fiscalità privilegiata viene in soccorso l’articolo 47-bis, comma 1 del Tuir, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs n. 142/2018, secondo il quale “i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto”.
È altresì importante tenere in considerazione che:
- la norma antielusiva è comunque disapplicabile in caso di risposta favorevole a richiesta di interpello di cui all’articolo 167, comma 5 Tuir
- i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata, che tuttavia si riferiscono a utili generati in annualità in cui la società estera era considerata a tutti gli effetti a fiscalità ordinaria, non devono essere considerati come provenienti da un paradiso fiscale, ai sensi della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1007, legge n. 205/2017).
Riguardo la prevalenza delle disposizioni pattizie tributarie rispetto a quelle interne, vi è un orientamento giurisprudenziale e dottrinale pressoché unanime, vedasi tra le più recenti la sentenza n. 7202/2024 della Cassazione, la quale, dovendosi esprimere sul rapporto tra norma interna e norma convenzionale, ha ribadito la prevalenza della seconda in ragione della finalità di evitare fenomeni di doppia imposizione.
Tuttavia, in caso di “pianificazione fiscale aggressiva”, ossia nel caso di fenomeni abusivi, si verifica un’inversione sulla prevalenza delle norme; infatti, sono prevalenti le norme interne volte a contrastare tali fenomeni elusivi rispetto alle disposizioni convenzionali.
Quindi, i giudici di legittimità, in primis, hanno dovuto affrontare la problematica dell’abuso del diritto, il cui generale principio antielusivo è direttamente rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE.
La disciplina generale “anti abuso” è stata decodificata dal legislatore nazionale con l’introduzione del comma 1, articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e successive modificazioni, recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, il quale definisce quando un’operazione può essere considerata abusiva.
La norma antielusiva generale prevede che l’Amministrazione finanziaria debba identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
- l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”
- l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”
- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
Il mancato riscontro di anche solo uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina l’assenza di abusività.
Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono, comunque, considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Oltre alla norma generale antiabuso, il legislatore ha previsto norme antielusive specifiche come quelle oggetto di analisi nella sentenza commentata.
In secondo luogo, i giudici di piazza Cavour hanno dovuto affrontare la problematica dell’utilizzo di “società schermo”.
Il Commentario Ocse stabilisce che “l’utilizzo di società schermo può essere contrastato anche con disposizioni in materia di imprese estere partecipate” e che non è precluso per uno Stato contraente “assoggettare ad imposta i residenti sul reddito attribuibile alle partecipazioni detenute in determinati stati esteri”.
Quindi, per condividere l’esito dei giudizi di merito, ovvero che la normativa convenzionale prevalga in ogni caso sulle norme interne, bisogna constatare l’assenza del carattere abusivo dell’operazione oggetto di analisi.
La pronuncia
I giudici di Cassazione, richiamando l’orientamento di cui alla sentenza n. 29635/2019, hanno ribadito che tra norma bilaterale e norma comunitaria prevale quella pattizia.
Tuttavia, hanno evidenziato che nella fattispecie concreta, si sarebbe potuto rilevare l’eventuale artificiosità dello strumento posto in essere per percepirne gli utili; infatti, anziché avvenire tramite una partecipazione diretta, avviene con ben tre passaggi intermedi, ossia prima attraverso la partecipazione alla società tedesca, poi da quella tedesca alla società inglese e, infine, da quest’ultima a quella localizzata in un “paradiso fiscale”.
La Corte, richiamando sia l’articolo 6 della direttiva Adat del 12 luglio 2016 sia i chiarimenti forniti dal Commentario Ocse, ha rilevato che “i paesi contraenti possono adottare una disciplina antielusiva nei confronti di società schermo, ed esclude la fondatezza dell’interpretazione delle norme convenzionali nel senso che le stesse ostino all’assoggettamento ad imposta dei residenti sul reddito attribuibile alle partecipazioni detenute in determinati stati esteri”.
Con il termine “società schermo” si intente una costruzione artificiosa finalizzata ad “aggirare” la normativa domestica dei singoli Stati membri. Quindi, la funzione di questi “schermi” è l’ottenimento di un vantaggio fiscale tramite l’elusione della norma tributaria, senza alcun obiettivo di raggiungimento di un risultato economico, imprenditoriale o organizzativo. Questa tipologia di “pianificazione fiscale aggressiva”, che prevede l’adozione di “società schermo”, secondo i giudici di Piazza Cavour “è una forma di abuso del diritto”.
La sentenza, tenendo presente l’orientamento giurisprudenziale della Cgue, chiarisce che “[…] il campo di applicazione dell’abuso in presenza di una ‘società schermo’ […] ha assunto un ulteriore e più esteso significato: non solo ‘costruzione di puro artifizio’, ma anche ‘non genuina’”.
In dottrina e in giurisprudenza sono stati individuati alcuni elementi sintomatici della “no genuine economic activity”, quali ad esempio:
- l’inesistenza sostanziale di un complesso societario organizzato, professionale ed economicamente rilevante
- l’assenza dell’attività economica prevalente all’interno dello Stato
- l’esistenza di pattuizioni inter-company che prevedono l’obbligo di retrocessione del provento
- l’interposizione di una “conduit” che ovviamente non è la “beneficiaria effettiva” di un determinato provento
- lo svolgimento della prevalente attività della controllata in uno Stato diverso da quello della fonte
- l’arco temporale ristretto tra le operazioni intercorse tra le consociate
- l’assenza di valide ragioni extra fiscali che abbiano indotto la società a operare la delocalizzazione.
In conclusione, i giudici di legittimità hanno ritenuto la struttura “non genuina”, conseguentemente hanno rilevato la prevalenza delle norme interne antielusive rispetto a quelle convenzionali, confermando l’operato dell’Amministrazione finanziaria.
Conclusioni
La Corte suprema, con la sentenza in esame, ha affermato il seguente principio di diritto: “La ‘società schermo’ costituisce una forma di abuso del diritto, rilevante sia ai fini civilistici, come risultato dell’esercizio di un diritto oltre il limite ‘funzionale’ implicitamente previsto dalla singola norma, sia a fini tributari, quale strumento asservito al raggiungimento di un mero beneficio fiscale indebito. Essa assume significato non solo di ‘costruzione di puro artifizio’, finalizzata ad eludere la normativa dello Stato membro interessato, creando catene di società prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale, giustificando così una legislazione nazionale restrittiva della libertà di stabilimento, ma anche di attività ‘non genuina’. In proposito al fine di identificare una ‘no genuine economic activity’ vanno presi in esame […] l’interposizione di una (o anche più) società del gruppo, non beneficiarie effettive, tra la beneficiaria (titolare della partecipazione nella prima) e quella che realizza il provento (formalmente partecipata dalla prima). Per tali situazioni, ferma la prevalenza in via generale della disciplina pattizia, sia le pronunce che le disposizioni euro-unitarie, e in particolare il Commentario OCSE, di guida all’interpretazione della disciplina pattizia, consentono al legislatore nazionale la previsione di una disciplina antielusiva, volta a evitare tra l’altro che la disciplina pattizia possa essere strumentalizzata al fine di favorire finalità elusive”.