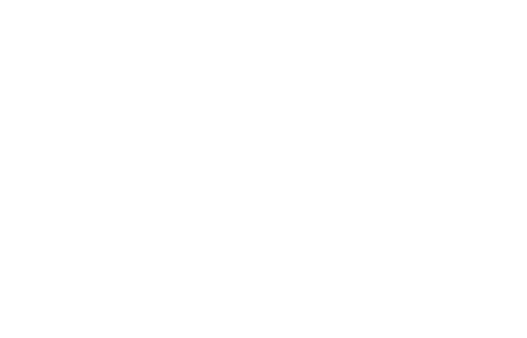Il Fisco ha provato l’inesistenza, ora tocca al contribuente smontarla
Se l’Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l’onere di dimostrare che ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto.
È il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 33620 del 1° dicembre 2023.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, è opportuno premettere che, in generale, si parla di “operazioni soggettivamente inesistenti” in riferimento a quelle operazioni che sono state effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dalla relativa documentazione contabile.
Si pensi, ad esempio, alla società “Alfa spa” che acquista un immobile dalla società “Beta srl”, ma la relativa fattura è emessa dalla società “Gamma srl”.
Il legislatore nazionale ha disciplinato le operazioni inesistenti con le seguenti disposizioni:
- articolo 21, settimo comma, del Dpr n. 633/1972, in base al quale “se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”
- articolo 1, lettera a) del Dlgs n. 74/2000, in base al quale “per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Nel caso in esame la vicenda giudiziaria è scaturita da un atto di accertamento, ai fini Iva, Ires e Irap, emesso nei confronti di una srl e della sua controllante, in relazione a operazioni, relative a compravendite di telefoni cellulari, ritenute dall’Amministrazione finanziaria soggettivamente inesistenti.
In sede contenziosa, i rilievi avanzati dalla società destinataria dell’accertamento sono stati accolti, sia dalla Ctp di Milano che dalla Ctr della Lombardia (pronuncia n. 2917 del 29 maggio 2014).
Alla base della decisione delle Commissioni tributarie vi è stata la circostanza che non era stata fornita adeguata prova attestante la partecipazione della società al meccanismo fraudolento.
I giudici della Corte di cassazione hanno richiamato il proprio consolidato orientamento in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (cfr pronunce nn. 9851/2018, 5339/2020 e 15369/2020) conforme a quello della Corte di giustizia europea (cfr decisioni del 6 settembre 2012 c- 324/2011, del 22 ottobre 2015 c-277/2014 e del 19 ottobre 2017 c- 101/2016).
Sulla base di tale orientamento, si è affermato:
- l’Amministrazione finanziaria che sostiene che la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un contesto di evasione d’imposta
- la prova della consapevolezza dell’evasione, però, non richiede che l’Amministrazione provi la partecipazione del soggetto all’accordo criminoso o la sua piena consapevolezza della frode. È, infatti, sufficiente che essa dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale e che, quindi, il contribuente era nelle condizioni di rendersi conto dell’inesistenza dell’altro contraente;
- una volta che l’Amministrazione ha fornito tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria, e cioè quella di dimostrare di aver agito senza la consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
I giudici hanno, altresì, affermato che, in linea generale, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Sussiste, però, un obbligo di verifica a suo carico se vi sono indici personali o operativi anomali tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione.
Nel caso in questione, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto imponibili alcune cessioni di beni, ritenendo che questi fossero stati esportati in altro Paese comunitario, solo fittiziamente. In tale contesto, secondo i giudici, il cedente aveva l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto e della consegna della merce nel territorio dello Stato di residenza del cessionario. Se il contribuente non fornisce tale prova, deve comunque dimostrare la sua buona fede e, cioè, deve dimostrare che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione d’imposta architettata dalla controparte.
I giudici della Cassazione hanno, inoltre, affermato che, a tutela della posizione del contribuente, nel caso in esame, non ha alcuna utilità dimostrare:
- la regolarità della contabilità
- la regolarità e la congruità dei pagamenti
- la mancanza di benefici derivanti dalla rivendita dei beni.
Ciò, in quanto “…si tratta di circostanze – le prime – già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e – l’ultima – perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode”.
Nel caso specifico si è ritenuto che l’esportazione della merce era solo fittizia, anche in considerazione del fatto che, nella stessa giornata e tra le stesse parti risultava riesportata in Italia, merce dello stesso tipo e per la stessa quantità, senza che la società fosse stata in grado di provare che si trattava di operazioni autonome.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, è stato, quindi, accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, confermando il principio in base al quale, in presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione ha assolto l’onere probatorio a suo carico, come sopra indicato, si verifica un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà provare la propria buona fede e la sua estraneità al meccanismo evasivo, nei limiti sopra delineati.